La Natura nella Terra di Mezzo
- Di Lorenzo Pennacchi
- 10 apr 2015
- Tempo di lettura: 4 min

Dal giornale online "L'intellettuale dissidente" del 14 Febbraio 2015
Il signore degli anelli è considerato un cult della letteratura fantasy, così tanto importante che si fa fatica ad immaginare l’intero genere senza questo testo. Un libro che parla del fantastico, o meglio, che si sviluppa all’interno di una realtà plasmata su misura dal genio di Tolkien soprattutto nel Silmarillion. Il professore profondamente cattolico di Oxford, infatti, non si è limitato ad inventare una storia, così come hanno fatto in molti prima e dopo di lui: ha creato un mondo, con le sue divinità, le sue razze e le loro lingue. Una storia fantastica sì, ma con forti significati reali. Del resto, il mondo del possibile sarebbe quanto mai banale se non servisse da critica propositiva nei confronti di quello reale. Ciò non significa affatto considerare, come hanno fatto in molti, Tolkien un pensatore di “destra” o di “sinistra”, un “fascista” o un “hippie”, e non significa nemmeno far della sua opera una grande allegoria, perché come scrisse lui stesso: «io però detesto cordialmente l’allegoria in tutte le sue manifestazioni e l’ho sempre detestata da quando sono diventato abbastanza vecchio e attento da scoprirne la presenza». All’allegoria si doveva preferire la storia con la sua “applicabilità”, che risiede “nella libertà del lettore e non nell’intenzionale imposizione dello scrittore”. Di fatto, l’opera tolkieniana non ci vuole dare letture definitive della realtà, ma farci ragione su di essa attraverso gli avvenimenti della Terra di Mezzo.
Molti sono i temi de Il signore degli anelli che hanno suscitato l’attenzione dei lettori e dei critici. L’infinita lotta tra bene e male, il percorso iniziatico degli eroi, la cosmogonia abilmente elaborata e le lingue minuziosamente inventate sono soltanto i più comuni. Ma ce n’è uno nell’intera vicenda dell’Anello, particolarmente significativo, che più di rado è stato analizzando. Questo è rappresentato dal ruolo positivo occupato dalla Natura, in diverse forme e salse, in contrasto con la degenerazione della tecnica. È parere di chi scrive che si possano rintracciare tre atteggiamenti differenti in questo ambito. Si cercherà brevemente di metterli in luce.
In primo luogo, c’è la realtà industriale e progressista di Mordor ed Isengard. Se la prima è l’incarnazione del male assoluto, la seconda è ancor di più il simbolo della degenerazione dettata dalla volontà di avere sempre più potere, da parte dello stregone Saruman, tesa a distruggere l’armonia e l’equilibrio naturale. Ecco la descrizione che ne fa Tolkien ne Le due Torri: «La terra infatti tramava. I pozzi percorrevano ripidi pendii sotterranei e scale a spirale conducevano a profonde caverne ove Saruman teneva i suoi tesori, i suoi magazzini, gli arsenali, le fucine e le grandi fornaci. Ivi ruote di ferro giravano ininterrottamente, martelli battevano; di notte pennacchi di fumo esalavano dalle condutture, illuminati dal basso di luce rossa, blu, o verde veleno». Una realtà industriale, malsana e innaturale, destinata però a perire, così come Mordor, ma non solo. Infatti, la condanna del progresso non traspare solamente nei confronti dei popoli del male, ma anche verso quelli del bene. È questo il caso del regno sotterraneo dei nani di Moria, così avidi e volenterosi di trovare sempre più mithril (“vero argento”), da risvegliare il Balrog, il flagello di Durin e la causa della loro rovina.
Tuttavia, come osserva Ezio Vaccari nel suo saggio Tecnologia, tecniche e…, è necessario distinguere tra tecniche e tecnologia. Secondo Tolkien, infatti, la seconda è la forma degenerata delle prime. Di fatto, le tecniche possono essere “buone” o “cattive” a seconda dell’uso che se ne fa. Se alcuni popoli, come visto, le utilizzano erroneamente, ce ne sono anche altri nella Terra di Mezzo, capaci di gestirle a dovere. È questo il caso degli hobbit, i mezzuomini abitanti della Contea (the Shire), una realtà contadina che non a caso ricorda il territorio “quasi rurale” dello Warwickshire nel quale Tolkien è cresciuto. La vita nella Contea è semplice e i suoi abitanti: «non capiscono e non amano macchinari più complessi del soffietto del fabbro, del mulino ad acqua o del telaio a mano, quantunque abilissimi nel maneggiare attrezzi di ogni tipo».
La Contea, così come altri regni umani tra cui quello dei “signori dei cavalli” di Rohan, incarna quella che si può definire, usando la terminologia del filosofo Arne Naess, ecologia superficiale. Di fatto, gli hobbit rispettano completamente il mondo naturale e i suoi equilibri, perché sanno che esso è la loro casa. Ma nella Terra di Mezzo c’è di più. Ci sono infatti diversi personaggi e popolazioni che rispettano la Natura, non per un tornaconto personale, ma perché la considerano come un bene in sé, un soggetto con cui dialogare e non un semplice oggetto da preservare. Questa visione è quella che Naess chiamerebbe ecologia profonda. Gli elfi dei boschi, l’enigmatico Tom Bombadil e il mago Radagast sono tutti portatori di questo legame profondo con la terra, i fiumi, gli alberi. Ma c’è ancora di più, perché nella realtà tolkieniana la natura prende letteralmente vita, manifestandosi come un vero e proprio soggetto. È questo il caso del Vecchio Uomo Salice, i fiumi e le montagne che si animano, le aquile che comunicano e salvano prontamente Gandalf e soprattutto gli Ent, i pastori degli alberi, prima vittime della degenerazione di Isengard e poi artefici della sua disfatta.
Insomma, ne Il signore degli anelli ritroviamo atteggiamenti differenti nei confronti della Natura, che sembrano andare però nella stessa direzione: quella della condanna di un mondo industriale, progressista e degenerato, che ha perso ogni forma di equilibrio e di connessione tra le differenti forme di vita. Del resto, Tolkien, molto critico nei confronti della società moderna, era un uomo semplice così tanto paragonabile ad una razza da lui stesso creata, come ammette in una delle sue Lettere al figlio Cristopher: «In realtà io sono uno hobbit (in tutto tranne che nella statura). Amo i giardini, gli alberi e le fattorie non meccanizzate; fumo la pipa e apprezzo il buon cibo semplice (non surgelato), ma detesto la cucina francese; mi piacciono, e oso persino indossarli anche in questi giorni cupi, i panciotti ornati. Vado matto per i funghi (raccolti nei campi); ho un senso dell’umorismo molto semplice (che anche i miei critici più entusiasti trovano noioso); vado a letto tardi e mi alzo tardi (quando mi è possibile). Non viaggio molto».

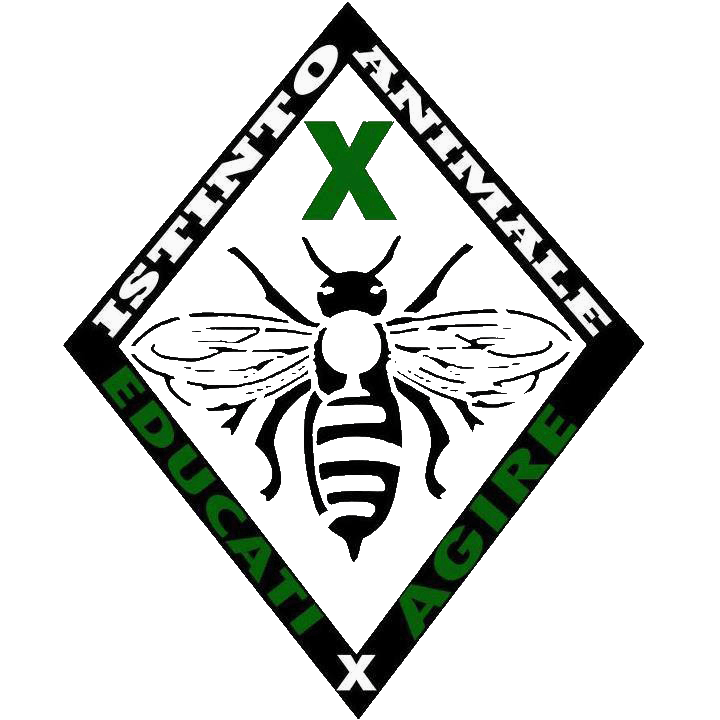





















Comments