Il Sacro e il profano
- Di Lorenzo Pennacchi
- 9 mar 2015
- Tempo di lettura: 3 min
Autore: Mircea Eliade
Anno di pubblicazione (originale): 1967
Casa editrice: Bollati Boringhieri
Pagine: 135
La Sacralità è una dimensione sconosciuta alla maggior parte delle persone del XXI secolo, soprattutto se si fa riferimento alla realtà globalizzata, di stampo occidentale, che domina il Pianeta. La nostra vita è stata (quasi) completamente desacralizzata, mentre nel passato ogni atto era compreso in una dimensione spirituale. In questo breve testo, Mircea Eliade, cosciente di questa triste realtà che ha fatto della Morte di Dio una vera e propria teologia, ci mostra come l’essere umano, pur avendo rinunciando coscientemente alla religione, ne conservi ancora il ricordo: «L’uomo areligioso allo stato pure, come si è detto, è un fenomeno piuttosto raro, anche nella società moderna più desacralizzata. La maggioranza dei “senza-religione” si comporta ancora, a loro insaputa, religiosamente». Insomma, per quanto noi possiamo credere di aver eliminato qualsiasi riferimento al Sacro nella nostra vita, esso si ripropone, in forme, seppur sempre più secolarizzate, ancora consistenti (basti pensare ai festeggiamenti per il nuovo anno, per il matrimonio e per la nascita di un bambino).
Tuttavia, le differenze tra la nostra esistenza profana e quella coscientemente sacrale di altri popoli, del passato e del presente, è evidente. Dall’Introduzione si può leggere: «Per la coscienza moderna, un atto fisiologico, l’alimentazione, la sessualità, ecc., non è nient’altro che un processo organico, qualsiasi siano i tabù che ancora lo ostacolano (regole di buona educazione a tavola, limiti imposti al comportamento sessuale dai “buoni costumi”). Ma per i “primitivi” un tale atto non è mai soltanto fisiologico; esso è, o può diventare, un “sacramento”, una comunione con il sacro». Questo accadeva, e accade ancora tutt’ora in diverse parti del Pianeta, perché il Sacro si manifesta a queste popolazioni, attraverso un atto che prende il nome di ierofania. Così nella manifestazione del Sacro, un oggetto comune cessa di essere se stesso e diviene il ganz andere, il “totalmente altro”: «Per coloro che hanno un’esperienza religiosa, tutta la Natura può rivelarsi come sacralità cosmica. Il Cosmo nella sua totalità può divenire una ierofania».
Così il cielo, una pietra e un albero cessano di essere semplicemente degli oggetti e divengono delle ierofanie, adorate in quanto tali. Alquanto suggestiva, in proposito, è la differenza evidenziata, nelle ultime pagine del libro, tra la concezione religiosa e areligiosa dell’Albero: «Di fronte a un albero qualunque, simbolo dell’Albero del Mondo e immagine della Vita cosmica, un uomo delle società premoderne è capace di raggiungere la più alta spiritualità: comprendendo il simbolo, è in grado di vivere l’universale […] L’immagine dell’Albero ricorre ancora frequentemente negli universi immaginari dell’uomo moderno areligioso; è la chiave della sua vita profonda, del dramma che si svolge nel suo inconscio e che interessa tutta la sua vita psicomentale e, pertanto, la sua stessa esistenza. Ma fintantoché il simbolo dell’Albero non avrà risvegliato la coscienza totale dell’uomo, rendendola “aperta” all’universo, non si potrà dire che esso abbia adempiuto completamente alla sua funzione. Non ha “salvato” che in parte l’uomo dalla sua situazione individuale permettendogli, per esempio, d’integrare una crisi del profondo, ridandogli l’equilibrio psichico temporaneamente minacciato, ma non lo ha ancora elevato alla spiritualità, non è ancora riuscita a rivelargli una struttura del reale».
Questo esempio mostra, almeno in parte, come l’uomo religioso tenda a vivere nel Mondo, e non, come fa l’uomo profano, banalmente ad esistere. Il tempo, lo spazio, i simboli, i miti sono per lui “elementi” (se così si possono definire) essenziali, che variano di culto in culto, non riassumibili in poche righe e, come ammette lo stesso Eliade, né in un Trattato né tantomeno in un libricino come questo. Tuttavia, basta sfogliare queste poche pagine, per addentrarsi in una realtà sconosciuta ai più, troppo impegnati a santificare l’esistente desacralizzato della post-modernità e a bollare le diversità culturali come “incivili”, in nome di un Occidente degradato e sempre più distante dal Sacro per eccellenza, ovvero la Natura nel suo insieme.
È per questo che, al di là delle sue posizioni politiche, sulle quali tanto si è scritto e blaterato, ma poco si è riflettuto, non si può non considerare Mircea Eliade come uno dei più grandi storici delle religioni di sempre, capace di rigenerare credenze millenarie e soprattutto un Senso profondo nella vita di tutti, quasi come se svolgesse la funzione della festa nella vita religiosa, la quale: «non è la “commemorazione” di un evento mitico (quindi religioso), bensì la sua riattualizzazione».

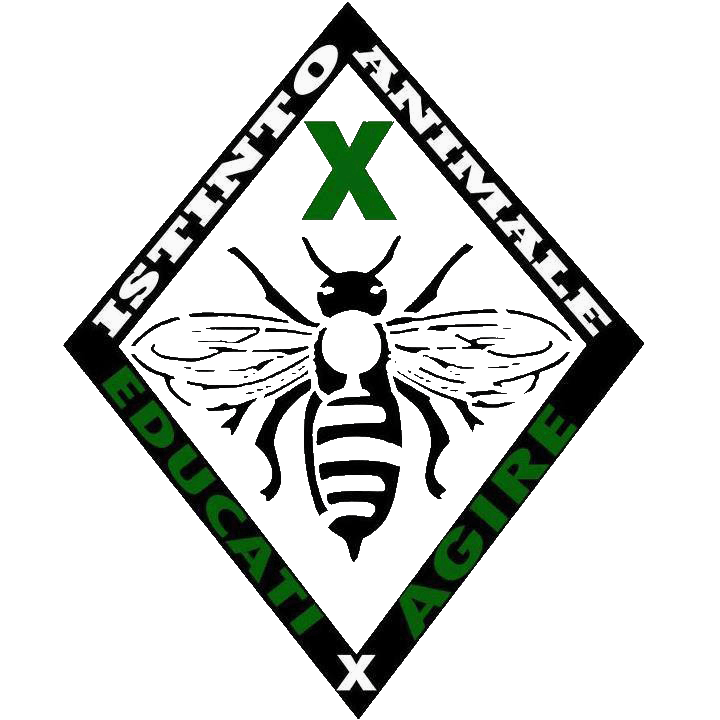





















Comments